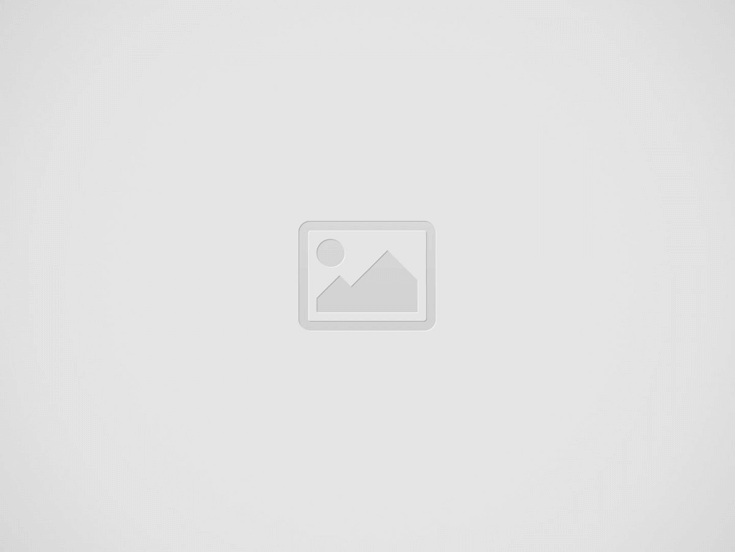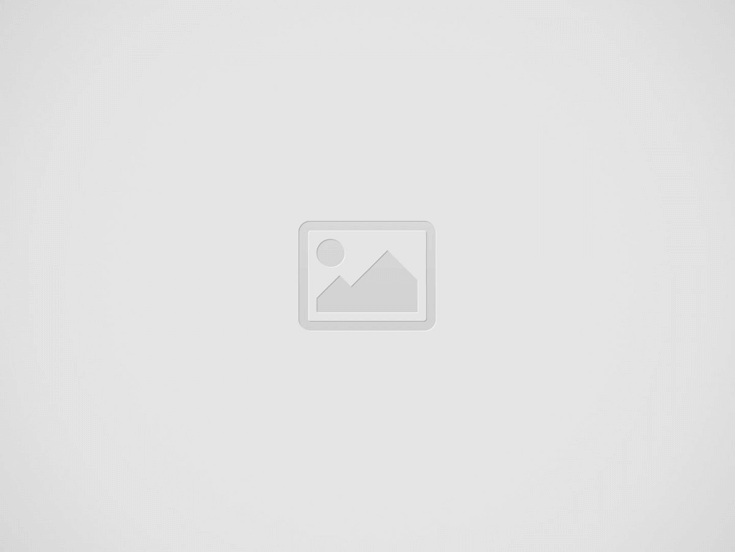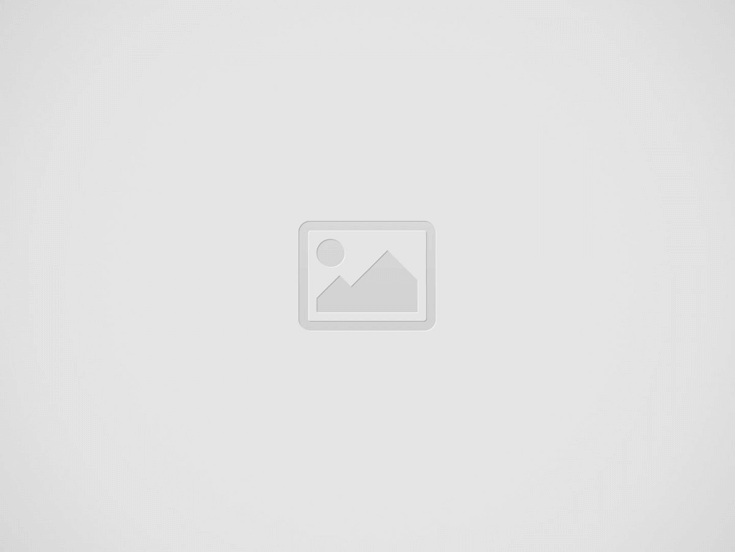
 “Mi chiamo Behnam Benoka, sacerdote di Bartella, una piccola città cristiana nei pressi di Mosul. Sono vicerettore del seminario cattolico a Ankawa. Oggi però mi trovo in una tenda che ho eretto con uno staff di medici e volontari per dare un soccorso medico ai nostri fratelli rifugiati dalla persecuzione”.
“Mi chiamo Behnam Benoka, sacerdote di Bartella, una piccola città cristiana nei pressi di Mosul. Sono vicerettore del seminario cattolico a Ankawa. Oggi però mi trovo in una tenda che ho eretto con uno staff di medici e volontari per dare un soccorso medico ai nostri fratelli rifugiati dalla persecuzione”.“Santità, la situazione delle tue pecorelle è miserabile, muoiono e hanno fame, i tuoi piccoli hanno paura e non ce la fanno più. Noi, sacerdoti, religiosi e religiose, siamo pochi e temiamo di non poter rispondere alle esigenze fisiche e psichiche dei tuoi e nostri figli”.
“Vorrei ringraziarti tanto, anzi, tantissimo perché ci porti sempre nel tuo cuore, mettici li sull’altare ove celebri la messa affinché Dio cancelli i nostri peccati e abbia misericordia di noi, e magari tolga da noi questo calice”.
“Le scrivo con le mie lacrime, perché qui siamo in una valle oscura in mezzo a un grande branco di lupi feroci. Santità, temo di perdere i tuoi piccoli soprattutto i neonati che ogni giorno faticano e s’indeboliscono di più, temo che la morte ne rapisca alcuni. Mandaci una tua benedizione per aver la forza di andare avanti e magari possiamo resistere ancora.
Ti voglio bene, Behnam Benoka”.
Questo è un estratto della lettera scritta dal sacerdote siro cattolico Benham Benoka a Papa Francesco lo scorso 18 agosto cui lo stesso Pontefice ha risposto con una telefonata il giorno dopo durante la quale ha chiesto a Dio il dono della perseveranza nella fede per gli iracheni cristiani. Sono passati pochi giorni dalla lettera disperata di Padre Benoka e qualcosa è cambiato, il branco di lupi feroci non è stato allontanato ma, anzi, è più numeroso, e dallo stesso sacerdote è partito un appello ancora più tragico. Ecco le sue parole:
Un asilo di massa Cari fratelli di tutto il mondo, Se volete veramente fare qualcosa per i cristiani in Iraq allora aiutateli ad avere asilo in Australia, USA o Europa. Ve lo dico non in mio nome ma in nome di tantissimi nostri fedeli che non cessano di chiedercelo ogni giorno. Da parte mia e di alcuni sacerdoti della diocesi di Mosul dei siri cattolici ci stiamo muovendo per chiedere un asilo di massa o di grossi gruppi per i nostri fedeli perchè l’emigrazione individuale non ci serve in quanto noi siamo comunità. La chiesa siro cattolica, infatti, è una delle chiese più piccole ed è presente soprattutto in Iraq, Siria, Libano. Se i nostri fedeli continueranno a fuggire singolarmente o con le famiglie significa che questa chiesa scomparirà dalla storia perché verrà disseminata in tutto il mondo. Con un’emigrazione di massa o di grandi gruppi potremo invece salvare ciò che ne è rimasto.
Sono parole importanti, queste, parole pesanti, se si considera la lotta che in tutti questi anni è stata fatta perchè i cristiani non sparissero dall’Iraq, ma che denotano il grado di disperazione cui essi sono arrivati.
Baghdadhope ha parlato conPadre Benoka che così le ha spiegate: “La gente non ha più speranza ed il problema ormai non è solo l’ISIS perchè i musulmani della Piana di Ninive, quelli con cui abbiamo sempre convissuto, stanno appropriandosi delle case e delle attività che i cristiani sono stati costretti a lasciare.
Che significato hanno, quindi, la convivenza o la cittadinanza?
Patria non vuol dire solo la terra ma anche la gente che la abita, la terra ed i nostri averi li abbiamo già persi e la gente ci ha traditi.
Di che paese parliamo? Di un paese che non ci vuole. Possono prenderci tutto ma non la nostra fede secondo la quale vogliamo vivere perché è sinonimo di vita.”

 Interrogato se la richiesta di alcuni dei sacerdoti siro cattolici di Mosul per un asilo di massa per i propri fedeli fosse o presagisse una richiesta ufficiale Padre Benoka ha risposto di parlare a nome di alcuni dei sacerdoti della diocesi di Mosul che sono a diretto contatto con i sofferenti, e non del Vescovo, l’unico a poter eventualmente ufficializzare una richiesta in tal senso anche se, fa notare con triste realismo, “a quale paese la si potrebbe avanzare? Nessun paese sembra disposto ad accogliere in massa i profughi cristiani.”
Interrogato se la richiesta di alcuni dei sacerdoti siro cattolici di Mosul per un asilo di massa per i propri fedeli fosse o presagisse una richiesta ufficiale Padre Benoka ha risposto di parlare a nome di alcuni dei sacerdoti della diocesi di Mosul che sono a diretto contatto con i sofferenti, e non del Vescovo, l’unico a poter eventualmente ufficializzare una richiesta in tal senso anche se, fa notare con triste realismo, “a quale paese la si potrebbe avanzare? Nessun paese sembra disposto ad accogliere in massa i profughi cristiani.”
Padre Benoka sa bene che le sue parole avranno un’eco perchè per la prima volta un sacerdote parla apertamente di sradicare l’intera, per quanto piccola, comunità della chiesa siro cattolica, ma spiega anche che non può tacere e che, sì, ha chiesto al Santo Padre la benedizione per avere la forza di resistere ma che a farlo possono essere i religiosi ma non più i civili che sono allo stremo.
“Noi non sappiamo più come rispondere alle loro esigenze, non siamo esperti in questo campo. Non sono solo i problemi materiali che ci angosciano ma anche la dignità ed i valori umani che in queste misere condizioni stanno sparendo. Non c’è più alcuna luce in fondo al tunnel, non più” Padre Benoka è responsabile del dispensario medico del campo profughi del santuario di Mart Shmoni ad Ankawa che ospita dalle 400 alle 500 famiglie (con in media 5 componenti ognuna = 2000/2500 persone) anche se i numeri variano di giorno in giorno perché “le famiglie vanno e vengono e nessuno può contarle”
Ciò che racconta fa venire i brividi. “Quando le prime famiglie sono arrivate, magari dopo aver aspettato anche 12 ore sotto il sole per entrare ad Ankawa non avevamo nulla, nulla ripeto. Non c’erano tende, acqua, cibo, medicine, non avevamo neanche la luce. Subito è arrivata da me una famiglia con un bambino con la febbre alta ma io cosa potevo fare? Ho chiamato un amico medico che si è precipitato per aiutare e che è stato letteralmente travolto dalle persone in difficoltà. Bambini con la febbre, anziani disidratati, moltissimi casi di diarrea, malattie varie e per tutti la paura, lo shock di ciò che avevano subito. Abbiamo lavorato tutta la notte alla luce delle torcie distribuendo i pochi farmaci trovati.”
Ora c’è altro personale medico?
“A quel medico se ne sono aggiunti altri da Bartella, Qaraqosh, Mosul, Karamles, tutti volontari che ancora adesso cercano di fare il possibile ma non è affatto facile”
Come è organizzato il dispensario?
“Male ma non possiamo fare di più. Prendiamo le medicine, abbiamo dovuto comprarle da soli, i primi giorni mandavo i giovani ad elemosinare nelle farmacie della città e gli unici aiuti che abbiamo avuto sono arrivati o da singoli iracheni o da donazioni dall’estero, dai miei amici spagnoli, da un’associazione americana, da una francese e da una parrocchia in Italia.”
Sta dicendo quindi che in quel campo non opera nesssuna ONG e nessun organismo internazionale come ad esempio l’UNHCR?
“Nessuno, qui non è arrivato nessuno ad aiutare ed ogni giorno curiamo più di 500 persone che arrivano anche dagli altri campi o che vivono in città ma sono così poveri da non poter comprare le medicine. Compriamo tutto noi ma non sappiamo per quanto ancora potremo”
Avete ricevuto solo donazioni volontarie, e dalle istituzioni?
“Nulla, il governo ci ha umiliati destinando ad ogni famiglia 1.000.000 di dinari (circa 700$) che è una cifra ridicola considerando che la maggior parte delle persone che assistiamo è arrivata qui senza niente perchè costretta a fuggire in fretta o perchè quel poco che avevano è stato loro sequestrato dall’IS ai check point, e che nulla di quanto hanno dovuto lasciare sarà più loro. Neanche la Chiesa ha ancora dato nulla. Ciò che serve, oltre agli aiuti una tantum di cui siamo grati, è un sostegno continuo che ci permetta di gestire non solo le emergenze ma anche la quotidianità del campo.”
Ci parli di questa quotidianità.
“Io sono responsabile del dispensario mentre un altro sacerdote lo è del campo. Posso dire però che la vita è terribile. All’inizio la gente ha dormito per terra e nella chiesa, fin sotto l’altare, ora ci sono delle tende, non per tutti è chiaro visti i numeri, ma di giorno la temperatura all’interno può salire fino a 50°. Ci sono solo una quindicina di bagni (non chimici) e per il cibo noi compriamo ciò che serve che viene poi cucinato da una volontaria che prima aveva un ristorante. Sono queste condizioni che mi spingono a chiedere che queste persone vengano aiutate ad uscire dal paese. Che futuro hanno? Vivono in condizioni misere, non hanno più una casa o un lavoro, non hanno speranze di rimanere in Kurdistan dove la vita costa il triplo che altrove e che non può assorbire un così alto numero di persone nè dar loro lavoro. So di assumermi una grande responsabilità nel parlare di asilo di massa ma, credetemi, non posso più tacere. Costi quel che costi.”
.
.
.
.