Supplica alla Vergine della Rivelazione. Preghiera potente da recitare oggi, 12 aprile nella sua festa
Vergine Santissima della Rivelazione, che sei nella Trinita’ Divina, degnati, Ti preghiamo, di rivolgere a noi, il tuo sguardo misericordioso e benigno.
Oh Maria! Tu che sei la nostra potente avvocata presso Dio, che con questa terra di peccato ottieni grazie e miracoli per la conversione degli increduli e dei peccatori, fa che otteniamo dal Tuo Figlio Gesù con la salvezza dell’anima, anche la perfetta salute del corpo, e le grazie di cui abbiamo bisogno.
Concedi alla Chiesa ed al Capo di essa, il Romano Pontefice, la gioia di vedere la conversione dei suoi nemici, la propagazione del Regno di Dio su tutta la terra, l’unita’ dei credenti in Cristo, la pace delle nazioni, affinchè possiamo meglio amarti e servirti in questa vita e meritare di venire un giorno a vederti e ringraziarti eternamente in Cielo.
Amen

Bruno Cornacchiola
Lontano vedo una luce ….Sono nato a Roma il 9 maggio 1913, in una stalla che aveva un fontanile in via Cassia Vecchia, in prossimità della quale oggi sorge la chiesa parrocchiale della Gran Madre di Dio.
Mia madre, che per arrotondare le insufficienti entrate di mio padre, faceva la lavandaia mi raccontava che mentre stava lavando i panni al fontanile le vennero le doglie e fu messa su un carretto.
Quante volte, da ragazzo, ho visto la poverina lavare i panni altrui, spesso cantando, accompagnata da muggiti e nitriti, e dal piccolo coro di galli e galline… Io aiutavo mamma a lavare i panni più piccoli. Vivevamo infatti in cascinali e in case rurali all’estrema periferia di Roma, in zone extraurbane, perché la povertà dei miei non ci permetteva di più, né ci consentiva di pagare puntualmente l’affitto, rimanendo a lungo nella stessa abitazione
A tre mesi, il 15 agosto, solennità di Maria Santissima Assunta in Cielo, fui battezzato nella Chiesa di Sant’Agnese fuori le Mura, alla via Nomentana sorta sulle catacombe che accoglievano i resti della giovane Martire.
Mamma mi raccontava non senza sorridere, che mio padre ed il padrino certo Mario Carnevale, da lui conosciuto nel Carcere di Regina Coeli, dove era stato rinchiuso per ubriachezza molesta e rissa, si presentarono al Parroco, col fiasco del vino in mano, malfermi sulle gambe.
Al Sacerdote esterrefatto, mio padre borbottò che voleva farmi battezzare col nome di Giordano Bruno: “Quello che voi preti avete bruciato vivo a Campo de’ Fiori!”; e qualora la cosa non gli fosse andata bene, avrebbe pensato lui a battezzarmi col fiasco del vino…
Invano, don Federico Fofi, cercò di dissuadere mio padre dal mettermi il nome di un monaco eretico, che il libero pensiero venera come maestro e grande annunciatore dell’umanesimo pagano. Rimaneva irremovibile. Finalmente le preghiere, la pazienza e le buone esortazioni del Sacerdote la vinsero sulla caparbietà di mio padre, che, invitato a rinunciare all’intero nome dell’orgoglioso monaco filosofo, accettò di prenderne soltanto il nome, o meglio, ignorante com’era, scelse il cognome, che per lui era il nome: Bruno.
Attraverso quel pio Sacerdote ricevetti dalla Chiesa “Madre della nostra nuova vita … la fede e la vita nuova in Cristo mediante il Battesimo” (cfr. C.C.C. Nn 168-169).
Come ho detto la mia famiglia era poverissima.
Mia madre non sapeva leggere né scrivere. Solo mio padre, poverino, anche egli analfabeta, aveva appreso a scrivere e leggere soltanto i numeri, lavorava saltuariamente e consumava quasi l’intero e magro salario nel vizio del bere. Quando poi era ubriaco erano risse, bestemmie, botte, bicchieri e stoviglie in frantumi… Non mancavano le coltellate e, di conseguenza, la galera. Quando beveva diventava ombroso e violento con tutti. Allora erano percosse e maltrattamenti per mamma e per noi bambini.
La vita dei miei genitori certo non era di buon esempio per noi figli, che cercavamo di imitarli nelle bestemmie e nelle parole triviali.
Ricordo una dolorosa vigilia di Natale, quando vidi le guardie ammanettare mio padre e tradurlo in carcere perché, ubriaco, aveva spaccato la testa ad un suo compagno d’osteria. Rivedo mia madre, lasciati noi bambini, affamati e disperati, e la pentola a bollire, con un po’ di verdura raccolta nei campi, scappare in questura nella speranza di essere utile al marito.
La poverina doveva lavorare senza sosta, sempre di corsa, e senza lamentarsi: governare la casa, inventarsi qualcosa da mangiare con quei pochi soldi che aveva, accudire a noi bambini, seguire i miei due fratelli più grandi ammalati, fare la lavandaia…
Papà si curava poco di noi figli. Anche mamma non ci poteva custodire suo malgrado, perché sempre assillata com’era da angustie e fatiche che non finivano mai, non riusciva a fare tutto. Molte volte, per fame, andavo a pescare nella marrana, dove ora c’è il mercato dell’usato in via Sannio, che passando sotto la via Appia andava a sbucare vicino a un mulino ad acqua e alla bottega di un marmista. Per guadagnare qualche tozzo di pane ballavo e saltavo, lacero e scalzo, nel cortile del casale della Signora Maria Luzzi in Daneri in Via Tre Madonne o Acqua Mariana, dove la mia famiglia abitò dal 1916 al 1929. La casa era quasi attaccata al palazzetto del dottore Buttazzoni, medico condotto della zona di Porta Metronia. Mi conducevano a fare questo “lavoretto” perché le persone che bevevano e giocavano a carte all’osteria non senza liti e bestemmie, si divertivano a sentire il suonatore ambulante di fisarmonica, e lo ricompensavano con qualche moneta. Egli poi mi dava qualche spicciolo.
In un’unica stanza, annerita dal fumo di un fornello che funzionava male piena di mosche l’estate, e sporca di fango l’inverno abitavamo tutti: mio padre, mia madre, i miei fratelli: Tullio (nato nel 1909) il maggiore, morto in giovane età, colpito da tbc; Mario (1911) che si ammalò di malaria che gli procurò una meningite cerebrale; io (1913), che fui colpito all’età di cinque anni da quell’epidemia, chiamata spagnola, che fece tante vittime; Augusta (1915) ed Elena (1918).
Abbandonati a noi stessi, circondati dalla più squallida miseria fisica e morale, noi bambini trascorrevamo una fanciullezza molto triste. Sempre affamati, spesso mangiavamo soltanto un pò di verdura raccolta da mia madre nei campi, o quello che riuscivamo a pescare dai rifiuti dei ristoranti e dell’osterie gettati nei bidoni, i “bigonzi”, come li chiamavamo noi, per nutrire i maiali.
Sporchi, mal vestiti e mal riparati dal freddo, crescevamo nella totale ignoranza religiosa morale e civica, in mezzo ai pericoli morali e materiali della strada. Mancavamo di tutto. Ricordo che delle volte, all’alba, dopo una notte Fredda, noi ragazzi correvamo a scaldarci sotto il primo raggio di sole che entrava nella stanza. Quando capitava, andavamo a gruppi a rubare per farne negli orti. Io sradicavo rape e verdure, poi fuggivamo, e portavo a mia madre quello che ero riuscito a portar via. Nel 1920 una folla assalì un negozio sulla via Vetulonia. Il proprietario, non faccio nomi, per salvare i suoi beni ci sparò con il fucile dalla finestra di casa. La gente che fuggiva mi trascinò per terra e mi calpestò! Avevo sette anni e rimasi dolorante per molto tempo. Portai a mia madre, come bottino, un rocchetto di filo metallico. La poveretta non sapeva proprio cosa farsene!
Fui spinto ad andare a scuola ma non fui mai seguito. Mi mancavano libri, quaderni, penne e ogni accessorio scolastico. Nessuno dei miei andò mai a parlare con gli insegnanti. Frequentai la prima elementare saltuariamente. All’insegnamento proficuo nelle aule chiuse preferivo quello all’aperto ma dannoso della strada. Dopo tre anni, per anzianità, fui promosso alla seconda classe elementare, che non riuscii a frequentare per l’intero anno perché, dopo due o tre mesi, lasciai la scuola. A dieci anni ebbi il mio primo lavoro come ragazzo di bottega di un carbonaio con l’incarico di consegnare a casa degli acquirenti il carbone. Quando passavo per via La Spezia; per il desiderio di conoscere almeno qualcosa, mi fermavo sotto le finestre della mia classe, che stava al primo piano della Scuola Elementare Giosuè Carducci. Qui, poggiavo in terra il sacchetto di dieci chili di carbone e ascoltavo, non visto e per poco tempo, la lezione della maestra. Qualche volta seguivo le operazioni aritmetiche, che sentivo dalla voce della maestra, scrivendo con il carbone sul marciapiede.
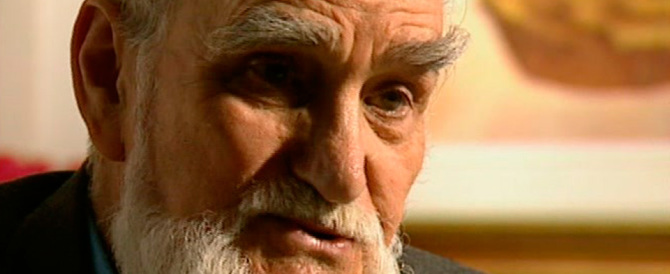
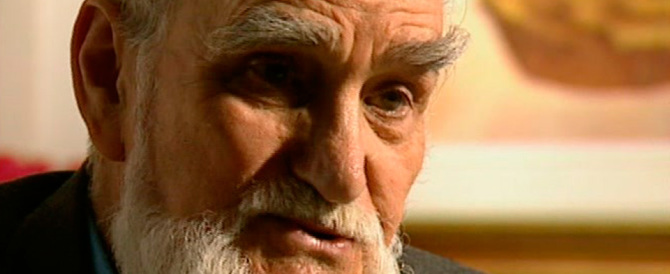
Ma purtroppo rubavo e fui cacciato. Ero molto attratto dai libri. Ricordo uno dei miei primi furti, nella casa di una signora alla quale avevo consegnato un sacchetto di carbone. Vidi all’ingresso un bel volume e non resistetti alla tentazione. Lo presi, aveva per titolo – Il catechismo di Pio X – (Ediz 1913); lo conservo ancora. Così finiscono i miei studi. Ormai ero cresciuto e per i miei genitori era un lusso mandarmi a scuola. Un lusso che non potevano permettersi.
Volentieri lasciai la scuola. Ormai per me ragazzo, lacero, spesso scalzo, o con la suola delle scarpe legata alla tomaia da cordicelle o da fili di ferro, la vergogna di sedere da ripetente, accanto a bambini ben vestiti ordinati, puliti e nutriti, forniti di libri e quaderni, era troppo grande.
Facevo anche qualche lavoretto saltuario e precario.
Feci lo strillone di giornali: Il Popolo d’italia, Il Messaggero, il Piccolo.
Ho lavorato anche come corriere al giornale di lingua francese “L’italie”. Il mio lavoro consisteva nel ritirare alla Camera dei Deputati gli articoli dei giornalisti e portarli in redazione, in Piazza di Pietra a Roma.
Un giorno, lavorando al banco dell’edicola dei giornali del Signor Giuliani, all’angolo di via Gallia, rubai cinque lire, una grossa cifra per quei tempi, che spesi comperando un pallone e tanti dolciumi, che spartii anche con i miei piccoli ed ammirati amici. Il padrone “fece la spia” a mio padre che mi impartì con la cinta una terribile ed indimenticabile lezione. Fui cacciato anche da lì, e andai a fare il garzone in un piccolo albergo di Via Veneto.
Mi viene in mente un fatto, accadutomi mentre lavoravo in Via Vittorio Veneto n. 79 vicino a Porta Pinciana nella pensione Calcagni – Gargiulo nel 1926. Facevo lo sguattero, lavavo il pavimento e accudivo ai piccoli mestieri. Terminato il mio lavoro andavo in Via Laurina a portare il latte alla mamma e alla sorella della signora Calcagni. Passavo per Trinità dei Monti dove, ai miei tempi, funzionava un ascensore, detto “del Pincio”. Alla fine di una lunga scalinata a destra, c’era una specia di arco, da lì proseguivo per Via del Babuino.
Il giorno di Natale, vedo in un angolo di Via Laurina, un Vecchio con la barba bianca. Mi chiama. C’era un fuoco acceso all’angolo destro, dove ora hanno costruito una fontana, mi giro e vedo lui, dolce, pieno di bontà, che mi dice: “Sono Paolo. Oggi è Natale. Voglio spiegarti cosa è il Natale.”
Io non sapevo cosa fosse o significasse la festa del Natale e chiedevo a tutti delle spiegazioni. Le ricevevo, sempre un po’ affrettate, ma non riuscivo a comprenderle, e continuavo a pensare al Natale come a una festa dei ricchi, che quel giorno mangiano tanti dolci e si fanno tra loro molti regali. Pensavo pure che come il Bambinello, chiamato Gesù, c’erano tanti altri bambini, ancora più poveri di lui, perché non avevano i genitori, e nessuno pensava a loro.
“Sappi – prosegue il Vegliardo – che noi stiamo nelle tenebre. Il Bambino è nato 1900 anni fa da Maria Semprevergine e senza peccato. Lei ha dato alla luce un Figlio, un Figlio che è la Luce e ci dà tutti Luce per illuminare il mondo…”
Chi poteva capire quelle sublimi parole? Io ascoltavo il racconto e pian piano mi addormentai tra le sue braccia… e mi sembrò di rivivere tutto quello che il vecchio Paolo mi narrava. Quando mi svegliai mi disse: “Vai a portare il latte alla madre della tua padrona. Ci rivediamo domani e ti narrerò altre cose che riguardano la salvezza dell’umanità “.
Ogni giorno, di pomeriggio, ero li ad ascoltare. Ascoltavo… ascoltavo.., era bello sentire quei racconti cosi profondi. “Un giorno vedrai quella Luce, e sarai tu un missionario della Luce… “mi diceva. Dopo non lo vidi più. Tutte queste cose le ricordai dopo l’Apparizione. Quando accadevano non sapevo chi fosse quel Vecchio e cosa volesse dirmi.
Ogni volta che ripenso a quel Natale e ai tanti che ho passato dopo, nell’abbandono, nella fame, nel freddo, nelle malattie, nelle guerre… mi rivedo sempre quello che ero: senza famiglia e senza amore.
Soltanto dopo il 12 aprile 1947, ogni Natale, anche nella sofferenza, furono e sono belli, pieni di luce. Sento il Natale come raggio di luce celestiale che penetra il cuore, che illumina. “Se un tempo eravate tenebra ora siete luce nel Signore. Comportatevi perciò come figli della luce, il frutto della luce consiste in ogni bontà, giustizia e verità” (Ef 5, 8-9). Aveva ragione il vecchio Paolo! Proprio vicino al luogo dove l’Apostolo Paolo fu ucciso, sulla Via Laurentina alle Tre Fontane, un altro Paolo (è il nome che ho preso da religioso fratello Leone Maria Paolo), povero e misero, vide quella Luce che penetra, si insedia, irradia la luce attorno a te per illuminare i cuori “luce per illuminare le genti / e gloria del tuo popolo Israele” (S. Lc 2,32). Cristo, la Grazia.
Ora sì che comprendo e posso dire: questo é il Natale, luce che illumina il retto cammino per la gioia eterna! Avanti per la strada della luce per la salvezza delle anime!
Se l’umanità comprendesse la luce di Cristo, lascerebbe la vita del mondo per la vita religiosa!




